L'intervento
Le narrazioni di malattia nella gestione delle patologie croniche
Erica Eugenia, Giovanni Bagliob
aSocietà Italiana di Antropologia Medica, Roma
bAgenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Roma
Citare come segue: Eugeni E, Baglio G. Le narrazioni di malattia nella gestione delle patologie croniche. Boll Epidemiol Naz 2024;5(4):37-43. DOI: https://doi.org/10.53225/BEN_100
Illness narratives in chronic disease management
An active involvement of the patient in the care process implies a socio-cultural shift within the healthcare and social services system, one that takes into account the patients’ perspective and their experience of illness. The repercussions of a chronic illness, in fact, impact not only the body but also the entire life and social context of the patient. Collecting illness narratives provides insight into the diversity of feelings, experiences, and challenges faced by those living with illness, offering valuable information for the proper calibration of service organization and policies. This, in turn, can improve the quality of care, reduce the increasing spread of litigation in healthcare, and address the growing use of defensive medicine.
Key words: active involvement of patients; chronic diseases; illness narratives; healthcare services; compliance
Introduzione
La sofferenza della persona malata nel discorso biomedico è spesso ridotta pressoché esclusivamente ai meccanismi neuro-biologici: sovente le implicazioni sociali che la malattia grave, la cronicità e l’invalidità comportano non vengono prese in considerazione e non si valuta il peso che questi aspetti hanno sulla vita del malato, sulla sua percezione di sé, sul suo sistema di relazioni. L’integrazione di un approccio biomedico con una prospettiva antropologica può fornire una comprensione della patologia che recuperi la complessità dell’evento malattia, non solo in quanto anormalità organica ma anche come esperienza vissuta dalla singola persona sofferente, con le relative interpretazioni del paziente basate sul suo universo culturale e sul suo mondo emozionale, tenendo in conto le relazioni sociali determinate dalla malattia e le sue conseguenze sullo status del paziente stesso (1).
In particolare, le narrazioni di malattia e cura ci permettono di indagare: 1) la malattia dal punto di vista del paziente; 2) i percorsi terapeutici e le risorse di salute - cioè le figure, i luoghi e i servizi coinvolti nella cura, afferenti all’ambito biomedico e non - connessi alla patologia, inclusa la gestione domestica della salute*; 3) la qualità percepita dei servizi offerti.
La disponibilità di informazioni su tali aspetti offre elementi utili a migliorare la relazione medico-paziente e la compliance nel processo di cura. Inoltre, un’analisi approfondita di come l’offerta e i professionisti sanitari siano percepiti dai pazienti permette di regolare e organizzare in modo più efficace le attività in essere e altre potenzialmente attuabili.
Analisi delle storie di malattia: alcuni temi
Esordio, diagnosi e interpretazione della malattia
La comunicazione della diagnosi di una patologia grave determina quella che Bury ha definito una “interruzione biografica” (2) e ratifica spesso l’inizio di un’esistenza di compromessi, in cui l’intensità dei dolori scandisce i giorni e li distingue in buoni e cattivi (3). La reazione alla comunicazione è spesso dominata dalla paura, soprattutto legata alla dimensione d’incertezza rispetto al decorso della patologia – aspetto questo che caratterizza in modo particolare le condizioni croniche – e ai suoi effetti sulla vita. Il tempo in alcuni casi garantisce l’accettazione della malattia, mentre in altri pone i pazienti, nell’esperienza quotidiana, di fronte a limitazioni e difficoltà delle quali non si erano inizialmente resi conto.
A volte la diagnosi arriva alla fine di un percorso di ricerca lungo e complesso e permette l’accesso a terapie efficaci che garantiscono, se non la guarigione, almeno un alleviamento dello stato di sofferenza. È il caso di alcune patologie autoimmuni in cui la comunicazione della diagnosi, nonostante il carico di incertezza e l’impatto distruttivo sulla vita della persona, è comunque accolta con sollievo, poiché permette l’attribuzione di un senso a un’esperienza irrelata di malessere e segna l’inizio di un percorso di cura.
La dimensione del senso è centrale quando si ha a che fare con la malattia. Non sempre, però, le interpretazioni e le spiegazioni che la biomedicina è in grado di fornire, soprattutto a livello eziologico, risultano sufficienti o soddisfacenti. Molti pazienti affetti da patologie gravemente invalidanti, se interrogati circa il momento in cui hanno avuto inizio i primi disagi, connettono in maniera più o meno esplicita l’emersione della malattia a un evento stressante della propria vita. Nelle narrazioni, l’insorgenza dei disturbi ritrova una propria collocazione all’interno della vita della persona e si connette spesso a esperienze o avvenimenti particolarmente coinvolgenti per la persona affetta da patologia da un punto di vista emotivo. Tali eventi, seppur non individuati direttamente come causa della patologia, vengono comunque messi in relazione con essa, restituendoci un’eziologia più o meno esplicita della malattia stessa per il paziente. Lo stress, una vita dura fatta di lavoro, sofferenza e privazione, come d’altronde l’inquinamento atmosferico sempre più diffuso e l’esposizione del corpo a sostanze chimiche potenzialmente contaminanti a volte costituiscono per i pazienti delle valide giustificazioni per un corpo che improvvisamente si ribella contro sé stesso, e contribuiscono a integrare o sostituire le informazioni offerte dalla biomedicina (4, 5). Questa, infatti, spesso non è in grado di fornire una motivazione sufficientemente convincente per il paziente e di rispondere alla domanda di senso fondamentale che ogni patologia grave o invalidante porta con sé: perché? E soprattutto: perché a me?
Non considerare che il significato attribuito dai pazienti all’esperienza di malattia in tutte le sue fasi (dall’insorgenza dei sintomi alla diagnosi, fino alla valutazione dell’efficacia di una terapia) può divergere rispetto a quello conferito dal medico finisce per avere delle ripercussioni negative sulla stessa pratica clinica, ad esempio in termini di compliance da parte del malato o di difficoltà nella presa in carico.
Il dolore
Il dolore presenta un impatto estremamente significativo sulla vita di chi ne fa esperienza e di chi lo circonda, e in questo senso esso ha una sua materiale evidenza (6). Gli stati caratterizzati dal dolore possono manifestarsi con durata e intensità diverse.
Il dolore acuto, anche se intenso, è comunque transitorio. Seppur temporaneamente invalidante, esso viene generalmente affrontato da chi lo percepisce come un’esperienza che avrà una fine, una risoluzione, e perde così parte della sua violenza destabilizzante.
Il dolore cronico, al contrario, si configura come un’esperienza totalmente diversa che fagocita la vita e la assorbe, divenendo parte sostanziale dell’esistenza stessa. Esso impedisce ogni consuetudine, disgrega ogni precedente “idea di normalità” e obbliga chi lo subisce a un’opera di rifondazione della propria realtà. Vengono meno tutte le attività che rendevano significativa la vita; le persone si vedono costrette a limitare o evitare drasticamente molto di ciò che un tempo era importante nella loro esistenza, a calibrare e adattare ogni attività quotidiana che possa rappresentare un rischio per la riacutizzazione del dolore, a ripensare non solo ogni singola azione da compiere, ma anche il proprio ruolo di individuo pienamente attivo nella famiglia, nel lavoro e nella società. Si può non essere più autosufficienti nelle faccende domestiche o non riuscire ad accudire i propri figli, si può avere la necessità di lasciare anticipatamente il lavoro o doverlo adattare a una condizione di volta in volta mutevole, soprattutto se si tratta di attività impegnative da un punto di vista fisico o che comunque comportano la messa in gioco di abilità che la persona non può più garantire in momenti di riacutizzazione del dolore. Il dolore cronico, così, costringe a una rivisitazione delle certezze individuali, nel tentativo di trovare un nuovo equilibrio tra “l’essere malato” e “l’essere sé” (7).
Reazione alla malattia (e alla terapia)
Nel quotidiano di persone affette da patologie gravemente invalidanti, vengono messe in atto strategie volte a mobilitare risorse sociali e materiali (8), ma anche personali. Queste strategie di convivenza, che i malati adottano per gestire le limitazioni imposte da tali malattie, sono diverse e di diversa natura e riguardano il presente e il futuro, un piano - potremmo dire - pragmatico, legato alle attività quotidiane, e uno più propriamente psicologico. Affrontare le limitazioni che una patologia impone in senso di sfida, senza arrendersi alla malattia, anche a proprio discapito,
ad esempio impegnandosi in attività faticose delle quali si sconterà il peso nei giorni o negli istanti immediatamente successivi, costituisce il primo modo attraverso il quale tentare di recuperare il possesso di sé e della propria vita, anche contro i consigli dei medici. La mancanza di compliance, dunque, costituisce in questo senso uno dei pochi modi che il malato possiede per ristabilire la separazione tra l’io che si è e l’io malato, quella separazione che la dimensione cronica, in quanto irreversibile, cancella. Aggirare o evitare le limitazioni imposte dalla patologia, a volte anche pagandone il prezzo in termini di sofferenza e di dolore fisico, costituisce un modo per sentirsi meno malati e per riprendere possesso di sé e del proprio corpo espropriato dalla patologia, nonostante le indicazioni contrarie dei clinici. È il caso di una giovane paziente affetta da una patologia autoimmune che, amando moltissimo il mare e pur essendo pienamente consapevole di non doversi esporre al sole, con l’inizio della bella stagione arrivava in reparto abbronzatissima e in tacchi a spillo, non certo in senso di sfida verso i clinici, ma per tutelare uno spazio di indipendenza rispetto alla malattia, coltivando un elemento che considerava fondamentale nella sua identità: la cura di sé e del suo aspetto**. In altri casi, al contrario, la fiducia che si ripone nel proprio corpo viene totalmente meno e l’incertezza legata al decorso della patologia assorbe a tal punto la vita quotidiana da impedire anche quanto concesso. Tale incertezza, nella maggior parte dei casi, si affronta impedendo a sé stessi di proiettarsi nel futuro, evitando di immaginarsi negli anni a venire e concentrandosi sul presente: se la speranza della guarigione non è una strada percorribile, allora il meglio che ci si possa augurare è che la situazione rimanga stabile e non peggiori ulteriormente. Altre volte, fronteggiare l’idea che si dovrà convivere per tutta la vita con una malattia impone l’autoinganno: far finta, per quanto possibile, che non si sia malati per contrastare l’impossibilità di vivere in un perenne stato d’eccezione, pur dovendosi confrontare ogni giorno col dolore che svela la precarietà di ogni finzione.
Nel quotidiano, anche operazioni banali necessitano dell’introduzione di tecniche di aggiramento che consentano di non chiedere aiuto ad altri e di garantirsi degli spazi di autosufficienza. Una paura ricorrente, in questo senso, è quella di dover dipendere da terzi e divenire un peso, o, più genericamente, di perdere la propria autonomia. In alcuni casi, tentare di fronteggiare anticipatamente, per quanto possibile, gli ulteriori limiti che la malattia potrà imporre nel futuro, anche nella prospettiva di non gravare ulteriormente sui familiari, costituisce un tentativo di mantenere una forma di controllo nella dimensione di instabilità e di incertezza che la patologia impone. Il timore che un giorno non si riuscirà a fare determinate cose o che queste non saranno più agevoli come prima induce a riorganizzare gli spazi della casa o a prepararsi a fronteggiare i possibili effetti della patologia. È questo il caso, ad esempio, di una paziente incontrata nel corso di un’indagine etnografica con soggetti affetti da una patologia autoimmune, che, essendo stata informata dai medici della possibilità di perdere la vista, si esercitava a “conoscere” e “praticare” la propria casa al buio e a occhi chiusi**.
Molte persone affette da patologia devono, poi, fare i conti non solamente con gli effetti della malattia sulla propria vita, ma anche con quelli dei trattamenti a cui si sottopongono e dei farmaci che vengono somministrati loro, i cui effetti collaterali si aggiungono alle sofferenze causate dalla patologia. L’impatto delle cure finisce così per confondersi con gli effetti della malattia e la terapia per catalizzare l’aggressività precedentemente riservata alla patologia (4, 5). Ad esempio, relativamente a trattamenti come la chemioterapia indagata da Marzano e Romano (9), o alla dialisi, l’impatto delle cure tanto sul corpo, quanto nei termini di dipendenza dagli spazi e dai tempi delle strutture ospedaliere, può essere invalidante al punto da venire percepito come una parte del problema. Il fatto stesso che la biomedicina non sia sempre in grado di garantire la guarigione o almeno di offrire la certezza di una condizione di benessere che si mantenga costante nel tempo toglie ai pazienti anche la possibilità di affrontare le sofferenze in una dimensione prospettica, di lungo respiro, di giustificare i sacrifici affrontati e le difficoltà sopportate, con la speranza di un radicale cambiamento della propria condizione. Vi è poi un ulteriore aspetto da considerare.
Il paziente attuale, quello che è stato definito nuovo “paziente contemporaneo”, con uno statuto diverso, un nuovo ruolo e una nuova identità sociale rispetto a quelli sviluppati a partire da anni ’50, è sempre più attivamente impegnato nelle proprie cure (10, 11). Questo sembra implicare una commistione sempre maggiore tra vita e malattia e, sebbene permetta ai malati di essere meno dipendenti dal personale sanitario e spesso anche dal contesto dei servizi, rischia di essere percepito in maniera ambivalente dai pazienti che, in alcuni casi, possono viverlo come un’ulteriore invasione degli spazi domestici da parte della malattia. Svolgere una terapia a domicilio, come testimoniano alcuni pazienti**, potrebbe equivalere ad accettare e a ratificare in maniera irreversibile l’identificazione tra il sé che si è, la propria condizione di malato e il ruolo di paziente. Mantenere separato lo spazio in cui si acquisisce lo status di paziente - quello in cui si svolge la terapia - da quello in cui l’identità non è definita dal rapporto con la patologia - il domicilio - per alcuni rappresenta anche un modo per proteggere i familiari dalla propria condizione di sofferenza. Allo stesso tempo, svolgere un trattamento in totale autonomia - è ancora la testimonianza di una paziente** - rischia di ridurre la cura alla mera erogazione di un farmaco, di svilire l’atto terapeutico e impoverirlo della sua componente relazionale, di affidamento e di presa in carico.
Impatto sul corpo, le attività quotidiane e lavorative
A volte i pazienti, per parlare della malattia e dell’impatto che essa ha sulla loro vita, adottano uno stile particolare (8), si esprimono per contrapposizione, in negativo potremmo dire, valorizzando tutto quello che facevano precedentemente alla comparsa dei sintomi. Le vite dei pazienti prima dell’insorgenza della malattia, così, sono spesso rappresentate come estremamente attive, dinamiche. Molti restituiscono un’idea di sé prima della malattia come persone instancabili, iperattive, sempre in movimento, opponendo questa condizione a quella in cui versano attualmente, quando tutto è faticoso, difficile, stancante e necessita di essere pensato, riflettuto, quando si è spesso costretti a un’immobilità forzata. È il caso, ad esempio, di un paziente sottoposto a trattamento emodialitico (4), che, invitato a raccontare la sua malattia, ha speso molto tempo nel descrivere quanto, in passato, amasse la campagna e la vita all’aria aperta che gli garantiva una grande libertà di movimento, ma anche quella solitudine, quella possibilità di “non essere guardato” che, ora che il suo corpo è costantemente manipolato e sotto osservazione, gli appare particolarmente desiderabile. Tutti raccontano la propria malattia “costruendo” per sé stessi una particolare identità da sani.
Le attività quotidiane, anche quelle apparentemente banali, perdono la loro connotazione di normalità e divengono a volte degli ostacoli insormontabili. La difficoltà di svolgere quello che prima si realizzava con facilità e disinvoltura si ripercuote sulla percezione del sé e sul modo di relazionarsi con il mondo esterno: il mondo, infatti, si modifica agli occhi della persona malata e le esperienze cambiano a loro volta, poiché “cambia il modo in cui si avvicinano al nostro corpo e così anche il sé cambia. Gli obiettivi non cambiano, ma si riconfigurano pian piano diversamente. Il mondo materiale diventa, come dire, meno strumentale, meno suscettibile di manipolazione, e c’è sempre più per aiutarci a sopravvivere” (12).
L’insorgenza di patologie gravi spesso comporta per i pazienti anche la modifica o l’abbandono delle attività lavorative precedentemente svolte, soprattutto se si trattava di attività impegnative da un punto di vista fisico o che comunque comportavano la messa in gioco di abilità che la persona non può più garantire, in modo particolare nei momenti di riacutizzazione del dolore. Questo può finire per aggravare ulteriormente la condizione del malato, aggiungendo alla frustrazione delle rinunce le difficoltà finanziarie. In alcuni casi, mantenersi autonomi ed essere in grado di svolgere una serie di attività come prima dell’insorgenza dei primi sintomi costituisce, invece, una necessità sostenuta dall’esigenza di mantenersi attivi, ma anche dal bisogno economico.
Cambia, per alcune condizioni, anche il rapporto con il corpo, poiché cambia il modo in cui esso viene “portato” e vissuto. È un corpo che non è più silente, ma che si impone prepotentemente al pensiero e alla percezione del paziente attraverso il dolore, che non risponde più in maniera “naturale” agli stimoli e che improvvisamente smette di collaborare. Inoltre, alcune patologie come quelle a cui si è fatto riferimento fino ad ora, ma anche alcune terapie o aspetti delle terapie (la chemioterapia, ad esempio, o la fistola arterovenosa nei pazienti in trattamento emodialitico) modificano profondamente il corpo di chi ne è affetto o di chi vi si sottopone, e questo può avere conseguenze nei rapporti con gli altri e sull’immagine che si ha di sé (12). I cambiamenti nell’aspetto, anche se non molto accentuati, costituiscono spesso oggetto di imbarazzo, soprattutto se suscitano l’attenzione o l’interesse di quanti ci sono intorno.
Rapporti interpersonali
Alcune patologie, così come alcune terapie, possono favorire la creazione di nuovi rapporti interpersonali o nuove forme di socialità (gruppi di sostegno e associazioni di persone malate), basati sulla condivisione di una comune esperienza di sofferenza o sulla frequentazione intensa e continuativa degli spazi ospedalieri, dove alcuni trattamenti vengono svolti contemporaneamente da più pazienti (4, 5). In alcuni casi, la partecipazione a gruppi di sostegno tra pari o il fatto di svolgere le terapie nel contesto ospedaliero e dunque con altri pazienti offrono una forma di benessere derivante dalla condivisione della propria condizione e dalla consapevolezza di non essere soli a vivere un’esperienza di sofferenza altrimenti incomprensibile per quanti non la provano. Non sempre i pazienti, però, vedono con favore la condivisione della propria storia o apprezzano il confronto con altre persone che soffrono a causa della stessa patologia. Alcuni ritengono inutile far conoscere la propria storia e conoscere quella altrui, poiché, anche se simili, le esperienze si considerano tutte diverse e incomparabili tra di loro. C’è una sorta di pudore rispetto alla conoscenza dell'altrui sofferenza, come fosse inopportuno indagarla, perché si è consapevoli che non si avrebbe, a propria volta, piacere di ricevere domande in merito, o perché si ha timore di ottenere risposte che potrebbero destabilizzare l’equilibrio ricostruito con fatica, innescando processi di proiezione verso un futuro al quale si guarda con terrore. Questi aspetti possono determinare una chiusura dei pazienti su loro stessi, inducendoli a vivere la propria patologia in solitudine, anche rispetto a quanti sono loro più prossimi. In questo senso, una patologia grave può contribuire a inficiare o rimodulare profondamente i ruoli e i rapporti familiari. Alle paure per il presente e per il futuro, alle incertezze per il decorso della patologia e al dolore che questa comporta, si aggiunge spesso anche il timore di poter essere a propria volta “causa” di sofferenza per i propri cari, soprattutto per i figli, rispetto ai quali non si ha solo paura di diventare un peso o un intralcio ma anche di poter trasmettere o aver trasmesso la malattia. Per evitare di essere compatiti ma anche di preoccupare i propri cari, alcuni pazienti nascondono la propria sofferenza e fingono un benessere che non provano. Di fronte alla sofferenza dei propri cari e al loro sconforto cercano di rassicurare e di minimizzare la propria condizione tentando, allo stesso tempo, di confortare sé stessi (5).
La paura di un aggravamento della propria condizione fisica e di una riacutizzazione del dolore induce, infine, a rinunciare preventivamente ad alcune attività di carattere sociale e aggregativo. Questo conduce inevitabilmente a ristrutturazioni e rimodulazioni dei rapporti interpersonali.
Risorse terapeutiche e riconoscimento della condizione di malattia
Nel corso di ricerche con pazienti affetti da patologie croniche (4, 5), questi hanno spesso dichiarato di avere alle spalle percorsi terapeutici lunghi e complessi, caratterizzati da alternanza di strutture e terapeuti del settore pubblico e privato, e della medicina allopatica e omeopatica. La gran parte degli spostamenti e dei cambiamenti, tuttavia, sembra collocarsi nella fase antecedente alla diagnosi o all’individuazione di una terapia efficace, quando ancora la persona è alla ricerca di una risposta allo stato di malessere. Rari sono, al contrario, gli spostamenti successivi all’individuazione della malattia, dopo la quale i pazienti tendono a fidelizzarsi alla struttura e al terapeuta che ha individuato la patologia, soprattutto se il percorso antecedente è stato particolarmente complesso e lo stato di sofferenza è molto avanzato. In questi casi, anche la sola individuazione della malattia, la capacità di trasformare dei segni fisici preoccupanti in sintomi che siano significativi da un punto di vista sociale, ovvero di attribuire un nome all’esperienza irrelata del dolore, costituiscono un passo significativo anche dal punto di vista del benessere del paziente, e sono parte integrante del percorso di cura.
Nella scelta dei centri e dei terapeuti a cui fare riferimento, fondamentali restano le indicazioni di conoscenti e amici che consigliano, indirizzano e spesso agevolano l’accesso dei malati, costituendo le principali fonti di informazione rispetto alle strutture e alle risorse disponibili per il trattamento della patologia. Il rapporto con il proprio medico di riferimento ha, ovviamente, un ruolo determinante nel processo di cura e assistenza del paziente. Alcuni pazienti si affidano completamente al proprio medico, anche per quanto riguarda il tipo di terapie disponibili e le informazioni in merito a eventuali novità relative alla ricerca scientifica. Altri non riescono a farlo e, pur riponendo generalmente fiducia nei clinici, tentano di mantenere, per quanto possibile, il controllo anche sul processo di cura (5). L’essere inseriti all’interno di un percorso di cura in una struttura specializzata, con medici e operatori sanitari che dimostrino di sapersi far carico del paziente e della sua patologia non solo dal punto di vista clinico, ma anche sotto l’aspetto psicologico e relazionale, rappresenta un punto fermo per i pazienti, che permette di fronteggiare con fiducia e serenità il proprio iter terapeutico e più in generale la propria condizione. La qualità del rapporto medico-paziente e più generalmente operatore-paziente, dunque, si riconferma come aspetto fondamentale del processo di cura, soprattutto nei casi in cui la biomedicina non sia in grado di restituire al malato il suo corpo sano, ma solo una normalità temporanea e il rapporto con le strutture terapeutiche si configuri come un aspetto imprescindibile nella vita della persona (5, 13).
Il medico di riferimento, e in particolare la relazione intrattenuta con lui tanto da un punto di vista clinico quanto personale, costituisce dunque l’elemento determinante nel processo terapeutico. Soprattutto nel caso delle condizioni croniche, la continuità della relazione con il medico - tanto più se si tratta del terapeuta che ha individuato la patologia all’interno di un percorso di ricerca di salute particolarmente complesso per il paziente -, e la sensazione di essere preso globalmente in carico da parte del personale ospedaliero sono parte integrante del processo di cura, al pari dei trattamenti di natura farmacologica.
La realizzazione di attività di tipo assistenziale al domicilio, in alternativa al contesto ospedaliero, non rappresenta necessariamente una soluzione ottimale per tutti, ma una proposta che deve essere valutata e discussa con ogni singolo paziente. Rilevante è, infatti, la paura di essere “dimenticati”, perdendo un’importante occasione di contatto con la struttura ospedaliera, soprattutto per quei pazienti che sono arrivati alla diagnosi dopo un percorso complesso. Importanza è anche talora riconosciuta alla possibilità di confronto e scambio con gli altri pazienti, contro l’isolamento in cui i malati si sentirebbero relegati restando nella propria casa, luogo dove spesso passano già la maggior parte delle loro giornate. Per alcuni pazienti, inoltre, recarsi mensilmente negli spazi ospedalieri equivale a rivendicare una propria autonomia, mantenere uno spazio di azione e di controllo rispetto alle proprie vite.
Anche il processo di riconoscimento dell’handicap determinato dalla patologia, che consente l’accesso alle agevolazioni di tipo economico, può costituire una fonte di difficoltà. Il percorso che conduce all’ottenimento spesso finisce per configurarsi come un complesso percorso a ostacoli, soprattutto nel caso della richiesta di riconoscimento dell’invalidità, in cui sono coinvolti medici e legali. Il fatto che non sempre le modificazioni fisiche dovute ad alcune patologie siano evidenti e soprattutto che il dolore non sia visibile rende non solo in molti casi complesso l’accertamento, ma anche umiliante il percorso. Se per alcuni, inoltre, l’ottenimento di un certo grado di invalidità costituisce il riconoscimento di un proprio diritto attraverso la ratifica istituzionale delle limitazioni e della sofferenza, per altri la paura dello stigma rappresenta un deterrente forte anche solo alla richiesta.
Conclusioni
Quanto detto fin qui aiuta a comprendere come le ripercussioni generate da una patologia cronica non inficino e non si ripercuotano unicamente sul corpo, ma su tutta la vita del malato, quindi anche sulla sua esperienza vissuta e sul suo mondo sociale (7).
Come ha sottolineato Tullio Seppilli, non si può prescindere da una conoscenza “dei significati, dei valori e degli orizzonti di riferimento culturali e materiali che danno senso ai loro [dei pazienti] stili di vita, ai loro atteggiamenti verso salute e malattia, alle attese che motivano il loro stesso colloquio con il medico” (14), ai fini di una corretta calibrazione dei servizi e delle politiche. Per tale ragione, il ricorso a studi qualitativi e in particolare la raccolta di narrazioni di malattia a integrazione delle analisi epidemiologiche permette di arricchire il quadro conoscitivo a supporto delle scelte organizzative e gestionali (15).
Peraltro, ogni rapporto fra medico e paziente, in una certa misura anche all’interno della nostra stessa società, è un incontro tra culture, un luogo di reciproco confronto: se questo non avviene, possono esserci riverberi negativi anche sullo stesso processo di cura (14). Solo un approccio olistico da parte del personale sanitario, che sfidi la crescente burocratizzazione dei servizi e riesca a guardare al paziente nella sua complessità può produrre quel cambiamento nelle visioni e nelle pratiche della cura che, includendo e capitalizzando l'esperienza della malattia “vissuta” dai singoli sofferenti, sia in grado di favorire una presa in carico al contempo maggiormente efficace ed efficiente, e permettere la costruzione di una significativa relazione fiduciaria, tanto dal punto di vista del paziente nei riguardi del medico, quanto dal punto di vista del medico nei riguardi del paziente.
Tutto questo nella prospettiva di migliorare la qualità delle cure, combattere la crescente diffusione dei contenziosi in contesto sanitario e il ricorso alla medicina difensiva.
(*) Con “itinerari terapeutici”, da un punto di vista antropologico, si intende fare riferimento all’intero ventaglio delle scelte, delle decisioni e dei comportamenti che una persona assume per restaurare uno stato di salute che ritiene soddisfacente. L’obiettivo di questo aspetto dell’analisi è quello di ricostruire le differenti logiche terapeutiche e comprendere le ragioni delle numerose e diversificate scelte di cura, in rapporto alla complessità della malattia, e di ricostruire il ruolo svolto dalle differenti figure terapeutiche (i medici di famiglia, ad esempio) e delle variegate risorse (della medicina allopatica ed omeopatica). Con “gestione domestica della salute” si intende l’insieme dei sistemi tecnici e simbolici, i saperi, le rappresentazioni e le pratiche messe in atto nello spazio individuale, familiare e/o comunitario per fronteggiare eventi avvertiti come potenzialmente rischiosi per la salute, prima del ricorso a professionisti dell’ambito terapeutico.
(**) Interviste raccolte nell'ambito del “Progetto pilota per la valutazione di un servizio per la somministrazione territoriale di farmaci infusionali nei pazienti con artrite reumatoide”, realizzato tra il 2011 e il 2013 dall'Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio (ricerca non pubblicata).
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
Finanziamenti: nessuno.
Authorship: tutti gli autori hanno contribuito in modo significativo alla realizzazione di questo studio nella forma sottomessa.
Riferimenti bibliografici
- Seppilli T. Immigrants in Europe and health care strategies: an introductory outline. In Vulpiani P, Comelles JM, Van Dongen E (Ed.). Health for all, all in health. European experiences on health care for migrants. Perugia: Cidis/Alisei; 2000. p. 31-43.
- Bury M. Chronic illness as biographical disruption. Sociol Health Illn 1982;4(2):167-82. doi: 10.1111/1467-9566.ep11339939
- Charmaz K. Good Days, Bad days: The Self in Chronic Illness and Time. New Brunswick: Rutgers University Press; 1991.
- Eugeni E. Come parlano i corpi secchi: narrazioni di malattia in emodialisi a Roma. La Ricerca Folklorica 2008;58:61-8.
- Eugeni E. Vivere da malato: sorveglianza e resistenza. Rassegna Italiana di Sociologia 2009;50(1): 49-74. doi: 10.1423/29064
- Pizza G. Antropologia medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo. Roma: Carocci; 2005.
- Honkasalo ML. Vicissitudes of pain and suffering: chronic pain and liminality. Med Anthropol 2001 ;19(4 ): 319-53. doi: 10.1080/01459740.2001.9966181
- Bury M. Sulla malattia cronica e la disabilità. Salute e Società 2005;4(1):147-64.
- Marzano M, Romano V. “Io voglio essere come prima…”. Cronicità e normalità nei racconti dei malati di cancro. Rassegna Italiana di Sociologia 2007;48(1):57-90. doi: 10.1423/24113
- Fainzang S. La relation médecins-malades: information et mensonge. Paris: PUF; 2006.
- Akrich M, Rabeharisoa V. L’expertise profane dans les associations de patients, un outil de démocratie sanitaire. Santé Publique 2012;24(1):69-74. doi: 10.3917/spub.121.0069
- Nguyen VK. Il corpo critico e la critica della razionalità: l’Aids e la produzione di esperienza in un ospedale universitario nordamericano. In: Pandolfi M (Ed.). Perché il corpo. Utopia, sofferenza, desiderio. Roma: Meltemi 1996.
- Eugeni E. Living a chronic illness: a condition between care and strategies. In: Fainzang S, Haxaire C (Ed.). Of bodies and symptoms. Anthropological perspectives on their social and medical treatment. Terragona: URV Publicacions; 2011. 111-27 p.
- Seppilli T. Antropologia medica: fondamenti per una strategia. AM. Rivista della Società Italiana di Antropologia Medica 1996;1(1-2):7-22.
- Eugeni E. I metodi qualitativi nella ricerca epidemiologica e nella sanità pubblica. In: Baglio G, De Masi S, Mele A (Ed.). Epidemiologia pratica. Una guida per la clinica e la sanità pubblica. Roma: Il Pensiero Scientifico Editore; 2022. 389-416 p.
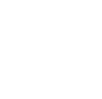
 Bollettino epidemiologico nazionale
Bollettino epidemiologico nazionale